Intorno a Napoletanità di Gigi Di Fiore
Gigi Di Fiore, Napoletanità. Dai Borbone a Pino Daniele viaggio nell’anima di un popolo, UTET, Milano 2019, p. 382, € 18
Si
inizia dalla constatazione di un paradosso: quanti scrittori ed artisti
napoletani, magari passati alla storia come cantori della napoletanità, hanno
preferito vivere lontano dalla propria città? «Si può essere napoletani, orgogliosi
di esserlo, innamorati della città, ma trovare insopportabile viverci» (p. 12).
È stato il caso – a cui Di Fiore dedica molto spazio – di Pino Daniele, che ha
preferito trasferirsi prima a Formia e poi in un paese della Maremma, dove
addirittura ha chiesto di essere sepolto; ma nei decenni è stato il caso di
Totò, dei fratelli De Filippo, di Raffaele La Capria, di Riccardo Pazzaglia…
A
quattro anni da La Nazione napoletana. Controstorie
borboniche e identità suddista (Utet, Torino 2015), Gigi Di Fiore torna sul
concetto di appartenenza al territorio e alla cultura napoletani e lo fa
sottolineando la profonda differenza tra napoletanismo
e napoletanità (o napoletaneria): il primo stereotipo
deteriore, cui tanti si adeguano «per pigrizia e a volte per interesse» (p. 12);
la seconda «l’orgoglio delle proprie radici e la coscienza di avere alle spalle
una storia antica» (ibidem).
Per
approfondire questa dicotomia, l’Autore ripercorre tre secoli di storia
napoletana, partendo dall’arrivo di Carlo di Borbone (che sarebbe il caso di
iniziare a chiamare direttamente Carlo VII di Napoli e V di Sicilia), ma non manca
di accennare la fondamentale importanza dei due secoli precedenti, quelli
passati in unione con la Spagna: un’unione tanto stretta «che le differenze tra
i due centri [Napoli e Madrid] quasi non si distinguevano più» (p. 21).
Segue quindi una descrizione, piacevolissima, tanto da farsi perdonare qualche imprecisione o le inevitabili lacune (il testo vuole essere un libro di riflessioni sociologiche, non un saggio storico) del periodo borbonico, con le innovazioni tecnologiche, l’ampliamento urbanistico, la costruzione delle regge, dei teatri e degli ospedali (primo fra tutti il gigantesco Albergo dei Poveri, 103.000 m² contro i 14.000 m² della Reggia di Capodimonte), ma anche la discutibile (per non dire sciagurata) scelta della Prammatica sanzione del 6 ottobre 1759 con cui decise la «divisione della potenza Spagnuola dall’Italiana» e l’esclusione di ogni futura «unione della Monarchia di Spagna colla sovranità, e dominj Italiani», rendendo il Regno napoletano sì indipendente, ma assai più debole, come sarebbe stato dimostrato nel 1860…
Segue quindi una descrizione, piacevolissima, tanto da farsi perdonare qualche imprecisione o le inevitabili lacune (il testo vuole essere un libro di riflessioni sociologiche, non un saggio storico) del periodo borbonico, con le innovazioni tecnologiche, l’ampliamento urbanistico, la costruzione delle regge, dei teatri e degli ospedali (primo fra tutti il gigantesco Albergo dei Poveri, 103.000 m² contro i 14.000 m² della Reggia di Capodimonte), ma anche la discutibile (per non dire sciagurata) scelta della Prammatica sanzione del 6 ottobre 1759 con cui decise la «divisione della potenza Spagnuola dall’Italiana» e l’esclusione di ogni futura «unione della Monarchia di Spagna colla sovranità, e dominj Italiani», rendendo il Regno napoletano sì indipendente, ma assai più debole, come sarebbe stato dimostrato nel 1860…
E,
giungendo al periodo post-unitario, Di Fiore descrive la nascita del quotidiano
Il Mattino (lo stesso in cui, quasi
130 anni dopo, scrive anch’egli), la vita quotidiana di Croce nello studio di
Palazzo Filomarino, il rapporto tra la Città e il suo Santo protettore
(compresa la vicenda del tesoro riportato a Napoli dopo la guerra grazie al
guappo Giuseppe Navarra, detto il “re di Poggioreale”, che ne garantì la
sicurezza nel tragitto di tre giorni lungo le dissestate e malfrequentate
strade del 1947), il rapporto con gli intellettuali della seconda metà del
Novecento (partendo dal terribile quadro disegnato da Curzio Malaparte nel
famigerato romanzo La pelle).
Diviso
– come Nazione napoletana – in tre
sezioni (intitolate rispettivamente L’orgoglio
del passato, L’identità scippata,
L’ansia di riscatto) a loro volta suddivise
in tre capitoli (Il sogno di Carlo, Lazzari e lazzaroni, Il Banco di re Ferdinando; Lo spazio del “Mattino”, Il Banco perde, Le fabbriche di Partenope; Le
storie di don Benedetto, Il tesoro di
San Gennaro, Penne e volgarità), il
saggio non sempre lega strettamente il tema trattato al concetto di napoletanità: ma sempre, quando descrive
frammenti di storia partenopea, vengono alla luce interessanti spunti di
riflessione. È il caso, ad esempio, di un episodio avvenuto nel 1959, alla
vigilia del centenario dell’Unità, descritto nella partecipe rievocazione delle
vicende del Il Mattino dalle origini
ai nostri giorni. Allora il quotidiano (uno dei simboli della napoletanità) pubblicò
una serie di articoli “filo-borbonici” o, per lo meno, non anti-borbonici: «Solo
l’autorevolezza della direzione Ansaldo aveva reso possibile pubblicare
articoli che non parlavano solo male dei Borbone» (p, 157). In effetti c’era
voluto un Genovese (e per di più della famiglia Ansaldo, la cui industria
metalmeccanica contribuì all’affossamento degli opifici di Pietrarsa) per
recuperare la memoria storica duosiciliana, che evidentemente ai Napoletani
(con l’eccezione di Ferdinando Russo) creava un forte imbarazzo.
Già,
perché gli intellettuali partenopei tendono a vergognarsi del proprio passato, sia
esso ispanico, borbonico, unitario o fascista: «I napoletani, da masochisti, amano
parlare male di se stessi, ma non tollerano che altri parlino male di loro» (p.
283). Non è perciò casuale che il primo volume per così dire “revisionista”, Il Risorgimento visto dall’altra sponda. Verità
e giustizia per l’Italia meridionale (1967), sia stato scritto da un Piemontese,
l’ufficiale sabaudo Cesare Bertoletti: a parte Silvio Vitale e la sua rivista «L’Alfiere»
(nata nel 1960) – che però aveva un respiro molto più ampio – nessuno con una
reputazione da difendere avrebbe osato a quei tempi mettere in dubbio Mazzini e
Garibaldi.
E,
parlando d’intellettuali, è fondamentale una frase di Anna Maria Ortese, scritta
a proposito di Raffaele La Capria (del primo La Capria, va specificato), secondo
cui non rappresentava «Napoli, ma la cultura e i vizi e le virtù di una
borghesia più che altro meridionale, la cui patria finisce sempre per essere
Roma» (p. 282), se non – aggiungiamo noi – Parigi, come certi “intellettuali”
sulla scia dell’avvocato Marotta.
Come
accennato, Di Fiore tiene a separare la napoletanità dal napoletanismo, l’eleganza
dalla volgarità, la creatività dal “tirare a campare”, l’orgoglio dal pietismo,
l’operosità dall’assistenzialismo. Sembra, dunque, che esistano due Napoli: quella
dei lazzari (o terroni) e quella dei signori (i meridionali), quella della
plebe e quella dei gentiluomini del Sud (una volta si diceva galantuomini). E a tal proposito cita Amato Lamberti, sociologo fondatore dell’Osservatorio sulla camorra nel 1981, che si occupò della Napoli degli “ultimi” del nostro tempo, eredi – a suo dire – di quelli della Napoli “spagnola” e borbonica, il quale scrisse: «Non abitano a Napoli, ma alla Sanità, ai
Quartieri, ai Miracoli, al Lavinaio, a Scampia, a Ponticelli, a Pianura. Sono
altri luoghi che tutti insieme fanno un’altra città, sconosciuta ai napoletani,
che non hanno nessuna ragione per frequentarla, la città da temere. Una
distinzione che gli abitanti di queste “enclaves” ben conoscono, tant’è vero
che dicono andiamo a Napoli, quando
si muovono per raggiungere via Toledo, via Chiaia, piazza Dante, piazza
Plebiscito, il lungomare, la villa comunale» (p. 93).
Ma
forse non esistono due Napoli bensì tre, anzi quattro, perché la Napoli elevata,
quella signorile della napoletanità, può
essere a sua volta almeno tripartita: abbiamo al suo interno un’anima spagnola
(o meglio ispanica), una inglese e, soprattutto, una francese. C’è quindi una
Napoli dei progressisti che guarda a Parigi, una dei conservatori che ammira idealmente
Londra (o New York) e un’ultima, minoritaria ma radicata, di carattere
reazionario, che guarda non a Madrid, ma alla Napoli dei tempi in cui era
strettamente unita a Madrid.
La
prima, che vive ogni giorno come se fosse il gennaio del 1799, pronta a
snaturare la storia, a partire dalla toponomastica cittadina, che piange
costantemente i giacobini giustiziati a Piazza del Mercato, facendo di quelle
cento esecuzioni capitali il perno di tutta la storia della Città (che
identifica con il Regno) e addossando alla reazione borbonica tutti i mali
presenti, come se quei cento avessero rappresentato il gotha esclusivo della cultura napoletana e
come se i giacobini (tra truppe francesi e giudici napoletani) non avessero
massacrato diverse migliaia di “cittadini”: non solo rozzi e incolti lazzari, ma
anche rappresentanti della borghesia tanto esaltata da Marotta & co.
Al
fianco dei progressisti, diversi nei modi ma non nella sostanza, ci sono i
conservatori, gli “anglofili”, interessati più al futuro che al passato (come
se ci potesse essere un futuro senza passato) e quindi sostanzialmente indifferenti
a discussioni viscerali sulle problematiche storiche: tra di essi ci possono
essere filo-borbonici o filo-giacobini; un giorni possono esaltare
l’illuminismo napoletano e quello seguente la politica economica di Ferdinando
II, riconoscere lo splendore del periodo artistico “spagnolo” oppure
rammaricarsi per la mancata concessione della Costituzione. Non c’è
contraddizione, perché l’approfondimento storico-filosofico viene considerato
quantomeno superfluo. Si comportano, quindi, un po’ come il Principe di
Moliterno, che nel gennaio del 1799 si propose come capo dell’esercito popolare
e poi lo tradì, unendosi ai giacobini e cannoneggiando i Napoletani da Castel
Sant’Elmo. Ecco perché, laddove potessero decidere, riterrebbero inutile
modificare i nomi di alcune vie o spostare alcune statue: l’importante è
pensare allo sviluppo economico futuro, non “gingillarsi” nella sterile
contemplazione del passato…
Dal
versante opposto ci sono i tradizionalisti, a loro volta distinti – per non
dire divisi o addirittura contrapposti – in varie “correnti”, dai neoborbonici
ai carlisti. Tra di loro ci sono i nostalgici (forse la maggior parte), soprattutto
del periodo borbonico, per i quali la civiltà a Napoli è arrivata con Carlo, che
chiamano III anziché VII, ed è finita con Francesco II a Gaeta, come se non
fosse esistito niente prima e come se le cause della decadenza del Regno non
fossero da cercare in primo luogo in alcune discutibili scelte della dinastia
francese (dalla separazione delle Corone di Napoli e di Spagna all’abolizione
dei Sedili, dalla ricezione del Codice Napoleone al costante perdonismo
concretatosi nella suicida politica dell’amalgama) e soprattutto che non si
rendono conto che l’indipendenza (teorica: di fatto ci fu una subordinazione
alla Gran Bretagna) non fu un traguardo positivo, se congiunta alla debolezza: cioè
che è meglio essere secondi in un grande Impero che primi in un piccolo Regno…
I
tradizionalisti invece, pur riconoscendo ai Borbone grandi meriti, hanno una
visione diversa, ritenendo l’assolutismo una degenerazione della monarchia e sottolineando
che Carlo VII non arrivò in un deserto, ma in una delle città più sviluppate
della Cristianità.
In
particolare i Carlisti – caratterizzati dal riconoscimento della legittimità di
esercizio a fianco di quella d’origine (secondo cui non basta avere sangue
regale per poter regnare, ma occorre farlo rispettando i princìpi religiosi e
giuridici tradizionali) e dal rifarsi a una figura concreta di Monarca
(attualmente, Don Sisto Enrico di Borbone, legittimo Re delle Spagne ma anche
legittimo Re di Napoli) – respingono ogni forma di nostalgismo. Di conseguenza,
essi rifiutano da un lato ogni esaltazione aprioristica del passato preunitario
e dall’altro il vittimismo.
Quest’ultimo
è uno dei mali peggiori di un certo attuale meridionalismo, che purtroppo è tanto
radicato da impedire una effettiva rinascita del Sud, perché il vittimismo
porta al lassismo, alimentando l’autocommiserazione e l’autoconvincimento che,
comunque, ogni impresa al Sud sia comunque destinata a fallire per i
disegni distruttori del Nord. Di conseguenza, anziché rimboccarsi le maniche,
«armarsi e combattere l’oltraggiosa fortuna» si preferisce “andare sul sicuro”
e farsi cullare dall’assistenzialismo.
Così
si impedisce il risanamento culturale del territorio e la società meridionale
finisce per alzare bandiera bianca (non gigliata).
Gianandrea
de Antonellis
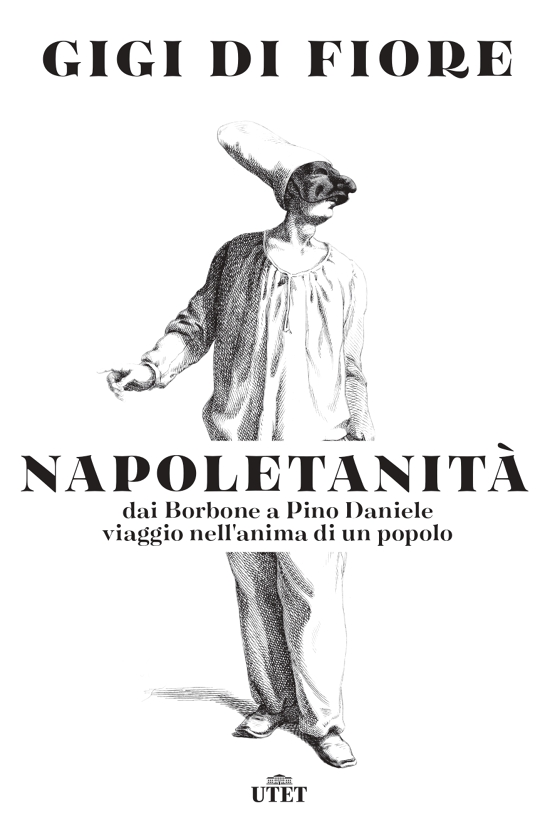
Nessun commento:
Posta un commento