I. La ciudad sin luz
II. Cárcel de tinieblas
Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970), è senza dubbio
uno dei massimi autori del nuovo secolo, da decenni riconosciuto come tale
anche da scrittori come Arturo Pérez-Reverte, membro della Real Academia Española, che ha definito Las máscaras del héroe (1996) «il miglior romanzo spagnolo degli
ultimi vent’anni» (Sobre
Borges y sobre gilipollas, 31 gennaio 2000), dopo aver
avuto parole di elogio per i sui esordi («romanziere di qualità superiore» (Un novelista de pata negra, in «El
Semanal»,
28 ottobre 1996) e come il regista Alex de la Iglesia, che proprio parlando
di questo suo ultimo libro ha affermato che è «divertente e si legge in un
niente, nonostante le sue 800 pagine, perché è scritto da quello che ritengo il
miglior scrittore spagnolo attuale», paragonando Mil ojos esconde la noche ad alcuni film di Scorsese.
Nato in Biscaglia e cresciuto a Zamora, giornalista di spicco (collabora continuativamente con il quotidiano ABC ed il settimanale culturale «XL», Juan Manuel de Prada ha condotto per anni Lágrimas en la lluvia, forse la migliore trasmissione culturale dell’intera storia della televisione (non solo spagnola), caratterizzata da un palinsesto che prevedeva il dibattito su un tema predefinito da parte di quattro autorevoli studiosi, dopo la visione di un film in tema con l’argomento scelto. La trasmissione era in diretta differita, quantunque possa sembrare incredibile nel rivedere le registrazioni, perché – a differenza degli usuali dibattiti televisivi contrassegnati da una costante gazzarra – imperava un assoluto rispetto da parte di tutti i partecipanti, nonostante le posizioni avverse.
Scrittore raffinatissimo, caratterizzato da
uno stile molto personale, definito “neobarocco” (in particolare utilizza un
numero di vocaboli molto superiore a quello della media degli scrittori
contemporanei), “esperpentico” (uno stile nato nella Spagna del Siglo de oro con Francisco de
Quevedo e riproposto negli anni Venti dello scorso secolo da Ramón del
Valle-Inclán, che si potrebbe tradurre alla lontana con “grottesco”) e “tremendista”
(più o meno traducibile con “granghignolesco”), creatore di affascinanti
neologismi, Manuel de Prada nei suoi interventi giornalistici ha difeso la
filosofia perenne, avendo il coraggio di indicare – tra gli altri – Aristotele,
la Bibbia e San Tommaso d’Aquino come fonti d’ispirazione. Non a caso, una sua
recente raccolta di saggi, si intitola emblematicamente Critica alla
totalità. Il pensiero tradizionale contro le ideologie moderne (Una enmienda a la totalidad. El pensamiento tradicional contra las
ideologías modernas, 2021).
Tra le sue opere di narrativa (ma anche gli
scritti saggistici e gli stessi articoli giornalistici sono sempre
caratterizzati da un sapore letterario) vanno annoverati i romanzi La tempestad (1997), Las esquinas del aire: en busca de Ana
María Martínez Sagi (2000), La vida invisible (2003), El séptimo
velo (2007), Me hallará la muerte (2012),
vincitori di premi letterari e spesso tradotti in italiano: Il silenzio del
pattinatore (E/O, 2002), Le maschere dell’eroe (E/O, 2000), La
tempesta (E/O, 1998 e 2001), Gli angoli dell’aria. Alla ricerca di Ana
Maria Martinez Sagi (E/O, 2001), La vita invisibile (E/O,
2006), Il settimo velo (Longanesi, 2008; TEA, 2010).
Tra i suoi romanzi più recenti – che
meriterebbero una traduzione – vanno menzionati El castillo de diamante (2015), sulla vita di Santa Teresa d’Ávila, e Morir bajo tu cielo (Morire sotto il tuo cielo, 2014), sugli “ultimi delle
Filippine”, cioè i cinquantuno eroi del distaccamento asserragliato nella
chiesa del villaggio di Baler, nell’isola di Luzón, che resistettero per
337 giorni (1° luglio 1898 – 2 giugno 1899) all’assedio della preponderante
forza dei ribelli filippini (800 uomini). Come a Civitella del Tronto nel 1861,
il comandante, privo di contatti con il mondo esterno, non volle credere alla
notizia che la Spagna avesse capitolato e continuò a combattere, provocando
circa 700 morti tra gli assedianti e limitando le proprie perdite a 17 uomini.
Venendo a Mil ojos esconde la noche, va detto che si
legge con continuo godimento e trasporto, nonostante la lunghezza, che ha
spinto l’editore a pubblicare il monumentale romanzo in due parti (La ciudad sin luz nel 2024 e Cárcel de tinieblas nel 2025); l’intero lavoro consta di 1.600 pagine complessive originariamente
scritte – udite, udite! – a mano usando carta riciclata (nel senso del dorso di
documenti vari: esistono alcune fotografie a confermare la veridicità di questa
asserzione). Afferma il medesimo autore: «Non è lo stesso scrivere a mano su
carta, impugnando la penna, che farlo su uno schermo, mediante il soave
ticchettio di una tastiera, con un computer. Quando uno scrive a mano, le parole
palpitano ed esultano, vibrano e si legano, si sposano e fecondano in una
maniera diversa e più intensa; in una maniera che alcuni forse noteranno, leggendo
Mil ojos esconde la noche. Ma il problema di scrivere a mano è che dopo bisogna ribattere lo
scritto, perché nelle case editrici ormai sono andati in pensione quei
tipografi che un tempo decifravano (e a volte miglioravano) i manoscritti dei nostri
classici». Una impresa che in questo caso è stata portata a termine dal padre
dello scrittore, il quale «può essere legittimamente considerato come autore
consorte».
Riguardo al contenuto dell’opera, va
innanzitutto specificato che Mil ojos esconde la noche pur
non essendo strettamente la continuazione de Le maschere dell’eroe, ne
condivide l’io narrante, Fernando Navales (un personaggio che si potrebbe definire brutto,
sentimentale ed – almeno inizialmente – ateo, a similitudine del
marchese di Bradomín, l’eroe ricorrente dei romanzi di Valle-Inclán, che si
definiva feo, sentimental
y católico: in quanto al primo aggettivo, lo
stesso Navales si paragona – per le fattezze del volto, non per l’altezza – a Piéral,
l’attore nano che appare, tra l’altro, come compagno di Fernando Rey nel
viaggio in treno che funge da cornice alla narrazione di Quell’oscuro oggetto del desiderio di Buñuel).
Ve detto che esiste una cesura tra il Navales delle Maschere
dell’eroe, che muore con infamia e senza lode nel 1942, esplicitamente declassato
dall’autore nelle ultime pagine a mero narratore – il vero protagonista, cui
spetta un crescendo all’interno del romanzo, è il bohemienne Pedro
Luis de Gálvez [1882-1940] – e il Navales de Mil ojos esconde la noche, che
attraversa indenne l’intera seconda guerra mondiale: non abbiamo più un
opportunista che casualmente si è trovato all’interno della Falange di José
Antonio Primo de Rivera, bensì un falangista convinto, fortemente critico per la
politica moderata (che ironicamente definisce nazional-seminarismo) imposta
dal disprezzato Franco.
Una parentesi: Francisco Franco, va ricordato
– o forse spiegato – non era affatto un falangista (o un fascista) né un
tradizionalista, bensì un militare interessato esclusivamente alla propria
carriera, indifferente tanto alla Monarchia quanto alla Repubblica, privo di
una particolare ideologia propria; un conservatore che si seppe adattare alla
situazione e, soprattutto, seppe mantenere a lungo il potere assoluto,
inizialmente conferitogli solo per il periodo bellico, dimostrando un attaccamento
alla poltrona degno del “miglior” Andreotti. Insomma, un perfetto democristiano:
l’epiteto di nazional-seminarista, quindi gli si addice benissimo.
Chiusa parentesi.
Tornando al romanzo, esso si apre nel 1940
(gli anni dal 1940 al 1944 scandiscono le sezioni dei due libri), nella Parigi
occupata dai Tedeschi, la ville lumière priva di luce del titolo,
e Fernando Navales viene incaricato dall’ambasciata di Spagna di avvicinare i
dissidenti spagnoli che dopo la guerra civile si sono rifugiati nella capitale
francese per convincerli a collaborare con una associazione artistica
ufficialmente promossa, a fini di riappacificamento, dal nuovo regime di Madrid
e dai vertici della Falange.
Navales contatta quindi i vari artisti ed uomini di cultura espatriati, nel
tentativo di una “riconciliazione nazionale” che (per il momento, cioè almeno
finché l’Asse sembra invincibile) riesce perché vari dissidenti desiderano
accumulare benemerenze per rientrare in patria, per la gloria di essere
considerati grandi oppure, più semplicemente, per sbarcare il lunario. Il
protagonista offre collaborazioni a (o citazioni su) giornali di spicco (ma per
scrivere o per essere elogiati sui quali bisogna ufficialmente schierarsi),
come il celebre (o famigerato) Je suis partout; la possibilità di
lavorare nelle accoglienti sale della accademia ufficiale spagnola, anziché in
squallide soffitte non riscaldate; di avere a disposizione materiali (tele,
pennelli, colori) e modelle; di ricevere interessanti sovvenzioni tramite l’ufficio
di propaganda tedesco (vale a dire da Goebbels), anch’esso interessato a creare
un ambiente di pacificazione culturale volto a giustificare il regime di
occupazione.
Numerosi sono i personaggi reali che il
falangista incontra e che cerca di attrarre alla propria causa: giornalisti e
critici (César González-Ruano, Sebastià Gasch), attrici e ballerine (María
Casares, Ana de Pombo), disegnatori (Carles Fontserè), pittori (Óscar Domínguez, Manuel
Viola), scultori (Mateo Hernández), pensatori (l’endocrinologo e filosofo Gregorio
Marañón)… Molti di questi nomi risultano poco noti al pubblico italiano medio,
ma si è spinti a leggere le loro biografie (o almeno le pagine enciclopediche a
loro dedicate), non fosse altro che per assicurarsi che siano realmente
esistiti (come altri personaggi del corpo diplomatico o della polizia politica:
Pedro Urraca, José Félix de Lequerica e Bernardo Rolland), per non parlare di Pilar
Primo de Rivera (sorella di José Antonio) o di Ramón Serrano Súñer (cognato del
generalissimo e perciò indicato come il Cognatissimo).
Sicuramente non ha invece bisogno di ricerche
la figura di Picasso, sul quale Juan Manuel de Prada scrive pagine
memorabilmente deliziose in cui smonta il ritratto di artista eccelso, svelandone
la natura narcisistica e riducendolo a “pintamonas” (imbrattatele), pur riconoscendone la
straordinaria abilità di trasformare in oro quanto tocca, pronto a sfruttare il
dubbio gusto dei suoi ammiratori e ad approfittare di qualsiasi occasione per
far soldi, anche mettendosi d’accordo con un bravo falsario ed autorizzandolo a
diffondere sue imitazioni come autentiche, purché gli versi il 50% degli
introiti…
Calunnie letterarie, falsificazioni
novellistiche? L’autore lo nega, ricordando il proprio profondo studio archivistico
sull’ambiente della comunità spagnola residente a Parigi; e in particolare,
sull’“imbrattatele” di Malaga, afferma: «Su Pablo Picasso abbiamo letto tutte
le biografie, le agiografie e le demonografie possibili e immaginabili, tanto
da farci un’opinione su un personaggio tanto degno di fama e di infamia».
Naturalmente, Navales non riesce (ma a dire la
verità, non lo tenta nemmeno) a convincere Picasso ad entrare nell’accademia “ufficiale”
della Spagna franchista: troppo ricco (conserva vari lingotti d’oro in casa)
per accettare sussidi, troppo internazionale per essere interessato a tornare
in patria, troppo famoso per necessitare protezione (i Tedeschi hanno l’ordine
di non torcergli un capello). Ma soprattutto troppo pieno di sé per mettersi
alla pari di altri artisti.
Memorabile il secondo incontro con il pittore
cubista (1941, VII): «Impetrai udienza a Sabartés, il cerbero innamorato di
Picasso, che me la concesse per la mattina della Domenica di Pasqua, perché l’imbrattatele
non osservava le feste (o, più precisamente, si considerava un dio tarchiato a
cui consacrarle tutte)».
Al colloquio è presente anche Ernst Jünger, allora
capitano della Wermacht di stanza a Parigi, venuto a riverire «il genio dell’arte
internazionale». Annoiato dalle banalità sulle bellezze parigine profuse dallo
scrittore tedesco mentre aspettano (il suddetto «genio» si diverte a far fare
loro anticamera), Navales commenta tra sé e sé: «Tutto il repertorio arcinoto, insomma,
dei barbari del Nord, sommersi dalla nebbia, di fronte ai frutti della luce
latina». Finalmente vengono ricevuti e «l’uomo più famoso del mondo» (parola di
Jünger!) si presenta
in calzoni corti, con una mappa dettagliatissima
delle sue ultime minzioni sulla patta. […] Dopo essersi grattato lo scroto, si
annusò la mano con piacere, prima di stringere quella del capitan Jünger, che
trattava, non so se umoristicamente, da gloria delle lettere tedesche. Anche Jünger
si annusò la mano dopo averla stretta a Picasso, con gesto di rassegnato
disgusto, come chi deve ingoiare una brodaglia esotica, per non sembrare
scortese al suo ospite giunto da qualche remota selva.
E quando il Tedesco si lancia in un’altisonante
interpretazione di Guernica,
Picasso gli sgonfiò il sufflè dell’entusiasmo
lirico, prima che traboccasse:
– Va bene, va bene; cerchiamo di non esagerare, altrimenti mi scoppiano le emorroidi. Sulla mia Guernica sono state fatte tutte le interpretazioni possibili e tutte mi sembrano meravigliose. Ma la verità è che, dato che non avevo letto niente sul celebre bombardamento, che non conoscevo né Guernica, né nulla di nulla, non sapevo come affrontare l’incarico che mi era stato assegnato. Allora il poeta Juan Larrea mi disse: «Pablo, tu hai sempre avuto una predilezione per la corrida. Immaginati, quindi, un toro che entra nell’arena, che viene infilzato da una marea di colpi di lancia e di banderillas infuocate, che riesce a scappare dalla plaza de toros furioso e insanguinato. Sbattendo a terra tutto ciò che incontra davanti a sé, entra in un negozio di porcellana, e lo distrugge, facendolo a pezzi. Capisci? È questo che avviene in un bombardamento». Ed è questo quello che ho dipinto: una corrida finita male, con il cavallo del picador imbizzarrito, il matador a terra, la sua cuadrilla impegnata nel quite e il toro che sta investendo una donna con il suo bambino. Né più né meno.
E dato che il capitan Jünger era rimasto in parte attonito e in parte intimorito dalla risposta bestiale e dal fragore dello scoppio di risa che la aveva accolta, Picasso gli batté sulla spalla, come se avesse voluto riaprirgli le cicatrici che si era guadagnato nella precedente guerra.
Questo passaggio, con tanto di citazione da Nelle
tempeste di acciaio (in cui Jünger enumera le ferite ricevute, contando
però solo i “fori di entrata” dei proiettili nemici ed escludendo quelli di
uscita) è solo un assaggio dello stile esperpentico di Juan
Manuel de Prada, della sua eccezionale capacità di scrittore, del suo modo di
riscrivere la storia e di creare una trama affascinante.
Il primo volume si chiude con un finale che
spiazza il lettore: il cattivissimo Fernando Navales inizia un percorso di
redenzione, che negli anni successivi lo porterà ad abbandonare il proprio
cinismo e a mettere a disposizione del bene il potere di cui dispone: dal
favorire l’espatrio di bambini ebrei al non denunciare un personaggio
compromesso con la Repubblica, della cui cattura – finalizzata a forzare Franco
a scendere in guerra – i Tedeschi lo hanno incaricato, non rivelandone nemmeno sotto
tortura il domicilio.
Non manca anche nella seconda parte un riferimento al “divino” Picasso, che apprezzando una fanciulla molto avvenente, afferma: «Per creare qualcosa di così bello, Dio ha dovuto essere qualcuno molto simile a me» [1944, IV], stimolando il sarcastico giudizio di Novales, che giudicando un preteso dramma dell’imbrattatele, commenta: «Questo Picasso, senza dubbio, è un genio del Rinascimento, uno scrittore tanto grande quanto vale come pittore». Ma se nel primo volume si incontrava un gran numero di pittori, nel secondo un notevole spazio è lasciato al cinema di Vichy: il protagonista assiste, tra le varie proiezioni, a quelle de L’amore e il diavolo (Les visiteurs du soir, 1942), Il corvo (Le corbeau, 1943), L’immortale leggenda (L’éternel retour, 1943); presenzia alla realizzazione di Perfidia (Les Dames du bois de Boulogne) o segue quella di Amanti perduti (Les Enfants du paradis – questi ultimi due usciti però entrambi nel 1945), in cui recita la spagnola María Casarès (1922-1996), tra le poche personalità dello spettacolo che Novales non è riuscito mai a coinvolgere nel suo progetto falangista. Il libro diventa così (anche) uno stimolo a (ri)vedere alcune interessanti pellicole storiche.
Non potevano mancare all’elenco delle
conoscenze di Novales gli scrittori francesi più politicamente attivi: Lucien
Rebatet (1903-1972), Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945, suicida al termine
della guerra, ma non per questioni strettamente politiche) e Robert Brasillac (1909-1945,
l’unico scrittore collaborazionista ad essere stato condannato a morte). E, a
proprosito di scrittori “impegnati”, se il “mostro sacro” demolito nella prima
parte del romanzo era stato Picasso, nella seconda una sorte simile (ma con più
benevolenza, anche visto il cambiamento di atteggiamento del protagonista) è il
malaticcio Albert Camus, preteso membro della Resistenza, di cui la citata María
Casarès si innamora perdutamente (complice anche la sua debolezza per le rughe
agli occhi!), certa che per lei lo scrittore franco-algerino lascerà la moglie:
«Il problema è che Albert ha lasciato ad Algeri una graziosa mogliettina che spera di ricongiungersi con il marito non appena la guerra sarà finita», ammise, con una specie di moderato dispetto. «Lui vuole che andiamo in esilio insieme in Messico, ma io vorrei continuare la mia carriera in Francia…».
Sospettai che lo volesse fare anche Camus; e che la proposta di quell’improbabile esilio in Messico non fosse altro che una boutade o una promessa da marinaio che quel partigiano dell’ultima ora tirava fuori dalla manica per ingannare Vitoliña [María Casarès] e avvolgerla nella sua nube di bacilli di Koch, mentre menava il can per l’aia. Mi dispiaceva che, alla fine, dopo essersi sbarazzata di tanti pretendenti più o meno testardi, Vitoliña finisse per trasformarsi nella concubina di un adultero, non importa quanto contornato di presunto genio letterario, di Resistenza da salotto e di zampe di gallina agli occhi, buone solo da mettere nello brodo. Ma Vitoliña aveva voluto infranciosarsi a tutti i costi; e in Francia non c’è istituzione così profondamente radicata come l’adulterio, che fino al XVIII secolo era goduto solo dalla nobiltà più danarosa e che, con la Rivoluzione, la borghesia risentita trasformò in un’istituzione pienamente nazionale, alla quale poteva finalmente avere accesso la gente comune (che, però, non poteva accedere ai beni della nobiltà, accaparrata dalla borghesia rivoluzionaria). La Francia, in realtà, non era altro che un allevamento ittico di adulteri che piluccavano un bocconcino, per dimostrare al loggione la propria adesione ai principi rivoluzionari; e Vitoliña, divenuta franciosa, aveva irrimediabilmente accettato la sua condanna.
Non
stupisca la ripetizione di alcuni vocaboli: è un tratto del barocchismo dell’Autore,
che ricorda anche il d’Annunzio (altro romanziere a cui per alcuni versi può
essere, mutatis mutandis, accostato) del Trionfo della Morte, in particolar modo per la
ripetizione – come un vero e proprio Leitmotive wagneriano, nel caso dello scrittore pescarese,
qui come semplice tema ripetuto – di alcune frasi o concetti. Ad esempio, le
ricorrenti citazioni (quasi trenta) del saggio su Tiberio di Gregorio
Marañón, a proposito del risentimento, atteggiamento che caratterizza decisamente
il protagonista. Eccolo alle prese con un violento sfogo verso gli artisti che
– ben sistematisi a Parigi e avendo fiutato il cambio della situazione bellica
– non desiderano più mischiare il proprio nome con quello della Falange e
rifiutano di partecipare a una esposizione da essa promossa:
Appena arrivato a casa, con il bosco ossidato
di Vincennes in lontananza, come in un autunno funebre, le mie dita si
precipitarono in una pioggia di insidie e delazioni sui tasti della mia
Olivetti, che cominciarono a tintinnare come una grandinata di stelle morte
sulla carta, ogni lettera come uno sputo di sangue nero, ogni parola come un
vomito di una infausta notte, ogni frase come un pugnale dal filo avvelenato,
lasciando sulla levigatezza della carta un bassorilievo di tradimenti e false
accuse, come un’improvvisa ondata di odio, senza abbellimenti formali o figure
retoriche, spogliato di tutti i tratti del mio stile, che improvvisamente mi risultavano
un’inutile ampollosità, perché il linguaggio è essenzialmente bello soltanto
quando accusa, quando condanna, quando ferisce, quando uccide. Il resto sono
chiacchiere e sprechi da dilettante, scrittura superflua del cuore, estetismo vano.
[1943, XII]
Non è solo risentimento per il mancato
successo “politico”: è anche disprezzo verso l’arte contemporanea, tanto
lontana dalla vera arte «come la pederastia dall’amore» (1942, X; un paragone
che ricorre quattro volte), che coinvolge anche i suoi autori, trattati con ironia
al vetriolo, godibile e amara («Gli artisti sono mossi esclusivamente dalla
vanità. […] Non dico che non esistano eccezioni, ma si contano solo sulle dita…
della mano che Cervantes perse a Lepanto» [1942, XVII]). Un vetriolo versato
non solo sugli artisti (o pretesi tali), ma anche sulla classe politica
spagnola, francese, tedesca e perfino italiana. Innumerevoli sono gli esempi.
Riportiamo solo il giudizio su José Luis Arrese (che aveva sostituito Ramón
Serrano Súñer a capo della Falange), incontrato da una delegazione di
giornalisti al ritorno da un suo viaggio in Germania e richiesto di dare
informazioni sulle fantomatiche “armi segrete”.
– Ve lo dirò, ve lo dirò, a condizione che non lo diciate a nessuno – accettò Arrese, dopo essersi fatto supplicare un po’ – Il Führer ha deciso di promuovere il generale von Paulus al rango di maresciallo. Come sicuramente saprete, nessun maresciallo tedesco si è mai arreso al nemico. Quindi la vittoria a Stalingrado è assicurata.
Mentre ascoltavo una simile idiozia, mi colse la nostalgia del cognatissimo che, oltre ad essere raffinato ed elegante, non aveva il cervello di un’ameba. Mi chiedevo se quel grassottello di Franco scegliesse simili elementi perché non gli facessero ombra e per poterli gestire a suo piacimento, o perché nascondesse una vocazione di collezionista di mostri allo stile di Picasso. [1943, II]
L’ironia cede però
talvolta il passo a considerazioni profonde:
Più eroico era stato il contributo di Giménez Caballero a «La Gaceta Literaria», dove era riuscito a far collaborare sia comunisti che fascisti, in un matrimonio bizzarro (o forse non così tanto). [1943, VIII]
Il morbo liberale imprime il suo carattere fino alla morte, non importa quanto lo si rinneghi. È come il sacramento del battesimo, ma al contrario. [1943, IX]
Come accennato, il romanzo è pieno di
riferimenti storici e letterari, che è un godimento scoprire a poco a poco (come
nel Pendolo di Foucault di Umberto Eco, che però contiene molti in-jokes comprensibili solo alla ristretta cerchia degli amici dello scrittore,
mentre qui sono citazioni alla portata di tutti – o almeno di tutti coloro che
amino e vogliano dedicarsi alla lettura dei classici e di approfondire le
biografie dei personaggi ritratti). Così avviene quando, dopo aver inutilmente cercato
di affascinare l’esule Victoria Kent (1898-1987), già Direttrice Generale delle
Prigioni sotto la Repubblica spagnola, affannosamente ricercata dalla Gestapo, spacciando
per propria una citazione altrui, interrotto con sufficienza senza nemmeno
essere riuscito a terminarla («So già quello che ha detto Pascal, la citano
sempre negli almanacchi»), si sente rivolgere «una frase che mi diceva
qualcosa, forse perché l’avevo letta anch’io negli almanacchi: “Quello che stai
per fare, fallo subito”» [1944, IV].
In questo suo romanzo Juan Manuel de Prada
sfoggia una eleganza di stile che rende emozionante il ritorno alla fruizione della
letteratura “alta”, che affascina profondamente, nonostante la distanza tra la
mole dei libri e la scarsità dell’azione (l’esatto contrario di quanto accade
nella letteratura “bassa” o “di consumo”), perché l’autore sa trasmettere il
piacere di leggere in sé, al di là dello svolgimento della vicenda narrata.
Così, quando il volume termina, siamo presi da un senso di tristezza, dato più
dalla fine della lettura in sé che dalla (amara) conclusione delle avventure di
Navales, che (a differenza del romanzo “precedente” Le maschere dell’eroe)
è riuscito con la sua trasformazione a conquistare la nostra simpatia, se non
addirittura la nostra empatia.
E ci consola, quindi, la promessa di Juan
Manuel de Prada di rivelarci le vicende vissute da Navales durante la guerra
civile, compiendo la promessa posta al termine de La ciudad sin luz,
prima di ammonire: «Ma, come abbiamo già detto in altre occasioni, non
scriviamo per la generazione presente, bensì per coloro che sono già morti e
per quelli che non sono ancora nati; tra i quali ovviamente conto te, amato
lettore, mon semblable,
mon frère».
Gianandrea de Antonellis
Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconde la noche. La ciudad sin luz, Espasa, Madrid 2024, p. 800
Idem, Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas, Espasa, Madrid 2025, p. 848

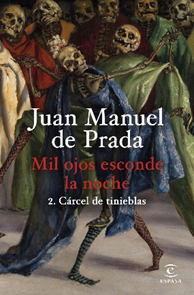
Nessun commento:
Posta un commento