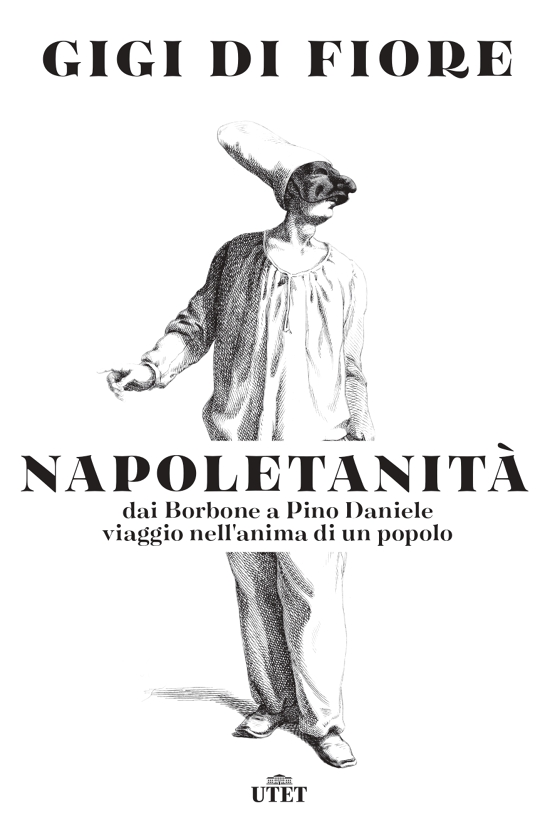Chi era Monaldo Leopardi?
Monaldo Leopardi, Catechismo sulle rivoluzioni e Otto giorni dedicati ai liberali illusi, Solfanelli, Chieti 2020, p. 168, € 14
Recensione di Giovanni D’Alessandro
Chi era Monaldo Leopardi? Era il padre del poeta Giacomo e c’è da giurare che moltissimi lo sappiano, magari sulla base di memorie scolastiche, insediatesi nei verdi anni grazie anche a un nome così inusuale e a un cognome così conosciuto. Il “signor padre” (1776-1847) – come lo chiamava con riverenza Giacomo nella corrispondenza intercorsa tra loro, dopo che il poeta aveva finalmente lasciato, a 27 anni, Recanati – era figlio del conte Giacomo (del quale darà al proprio primogenito il nome) e della marchesa Virginia Mosca di Pesaro, primo anch’egli dei discendenti d’una delle famiglie più illustri della Marca Pontificia. Orfano dai 4 anni, affidato a una tutela familiare, istruito da un precettore gesuita, Monaldo fu costretto a cimentarsi con l’amministrazione dei beni ereditari già prima dei vent’anni, con risultati disastrosi; che costrinsero, dopo il suo matrimonio nel 1797 con la marchesa Adelaide Antici – madre del poeta –, tanto la moglie quanto i parenti di lei a ritenere opportuno occuparsi loro dal patrimonio. sollevandone lo sposo e lasciandolo così libero di dedicarsi agli amati studi di filosofia, religione e politica; nonché di attendere alla costituzione della famosa biblioteca di ventimila volumi immortalata dal primogenito come alveo di “studi matti e disperatissimi”.
C’è una
premessa da fare, doverosa soprattutto quando si parla di un poeta d’immensa
fama e grandezza, quale Giacomo: come cioè sia destinato a risultare controverso
ogni riferimento sulla incidenza, nella sua opera, del contesto di provenienza
e formazione; ma con una distinzione rispetto ad altri grandi, che vi sono casi
in cui la famiglia appare meno condizionante e casi in cui si verifica l’ipotesi
opposta.